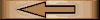 |
|
| STUDI |
|
Il pensiero sul male nell’antichità
Il problema del male ha sempre interessato il pensiero umano, ed è sempre stato
oggetto di affannose ricerche e appassionate discussioni.
In Persia, secondo il nazdeismo, antica religione iranico-persiana, rinnovata nel secolo VII o VI a. C., da Zoroastro, esistevano in lotta due divinità, Ahura Mazdàh e Ahriman, la prima buona, la seconda cattiva.
Sant’Agostino nella lotta contro il dualismo dei manichei, ha intuito che la nozione del male va intesa come difetto di bene. Il male non è una sostanza, ma una privazione.
In India Suddharta, detto Budda o illuminato, ha affermato che la vita è essenzialmente dolorosa nella nascita, nella vecchiaia e nella morte. La causa del dolore sta nell’attaccamento all’esistenza e ai beni.
In Grecia il poeta Omero era ottimista, Esiodo rimpiangeva l’età dell’oro, Teognide desiderava non essere nato, Solone preferiva la morte alla vita, Esiodo dichiarava Giove colpevole per avere ostacolato il piano di Prometeo, Sofocle ed Eschilo ritenevano il dolore una punizione ed una medicina degli dei.
I Filosofi socratici ritenevano che il dolore poteva essere vinto con l’ausilio della virtù; Epicuro ed Aristipo sostenevano che il dolore si poteva vincere con il ricorso al piacere; i cinici con il ricorso all’apatia.
A Roma gli stoici Marco Aurelio, Seneca, Epitteto hanno affrontato la sofferenza con l’indifferenza.
La ragione e il male
San Tommaso d’Aquino ha sostenuto che il male filosoficamente non si spiega. Dinnanzi al male l’uomo può diventare più santo o più ribelle.
Il filosofo Pareyson, in una conferenza tenuta nell’aula magna dell’Università statale di Macerata l’8 maggio 1986, ha detto che “sul problema del male e della sofferenza la Filosofia si è dimostrata, nel corso dei secoli, manchevole, se non addirittura insufficiente, al punto che non sembra azzardato affermare che Sant’Agostino e Pascal dicono sull’argomento cose profonde e lo fanno meno come filosofi che come cristiani… Solo a partire da Kant la situazione è cambiata. Il male affonda le sue radici nell’oscura profondità della natura umana e nei recessi rapporti dell’uomo con la trascendenza. Il problema del male come il problema del negativo in genere, riguarda assai meno l’etica (Filosofia) che la religione. La religione più che della colpa morale parla del peccato, anzi della caduta dell’uomo, che colloca in una grandiosa scena cosmica. Dio aveva creato l’uomo in una condizione di felicità. Il peccato è la causa del disastro cosmico. L’uomo con la sua libertà ha sconvolto il piano del creatore”.
Alcuni testimoni della sofferenza
Giovanna D’Arco (1412 – 1431)
La pastorella fu fortemente impressionata dalla presenza del dolore nella storia umana. E si domandava dolorante e perdutamente: “Perché il buon Dio permette che ci siano tante sofferenze? Perché l’eternità dell’inferno?”. E giungeva perfino a offrirsi, senza limiti di tempo, alla sofferenza per salvare i dannati dalla pena eterna. A fatica si arrendeva a Dio, che senza dubbio, è per il meglio1.
Albert Camus (1913 – 1960)
Nelle opere teatrali: Sisifo, Caligola, lo Straniero, Camus esprime la tesi dell’assurdo.
Il mitico Sisifo, che deve portare sulla cima di un monte una grande pietra, che gli sfugge dalle mani ogni volta che è prossimo alla meta, rappresenta l’assurdità della vita umana.
Caligola, che per la morte della sorella impazzisce e diventa cinico, crudele, violento, sadico, spregiudicato personifica il dolore non digerito. Il suo grido: “voglio la luna” consiste nel desiderare l’impossibile ed è un grido di rivolta contro un mondo immerso nel dolore.
Protagonista dello Straniero è Mearsault incapace di soffrire. Mearsault affronta il dolore da indifferente, da straniero, da apatico. Niente lo smuove, neppure la notizia della morte della madre, la sua condanna a morte per avere ucciso un uomo sulla spiaggia in stato di ubriachezza. Egli è un uomo senza emozioni, senza sentimenti.
Nella trilogia predomina l’assurdo.
Nel romanzo La peste entra in scena l’ateo dottor Rieux che si dedica all’assistenza degli appestati più bisognosi. Lo segue nel volontariato il dottor Tarrou, pure ateo, il quale muore contagiato.
Camus annota: “Se ci può essere un santo senza Dio, è il solo problema che io conosco”. E vi costruisce nel romanzo la Caduta il santo laico nella persona di Clemence, che lavora non per amore dei bisognosi, ma per l’affermazione della sua persona. Nel Capitolo IV della Peste Camus presenta una scena orripilante, raccapricciante. Accanto ad un bambino appestato, in lotta con la morte, vi si trovano Rieux, Tarrou e il padre gesuita Pameloux, impotenti, per ore e ore di fronte al male. Rieux si rivolta contro il cielo.
Camus, per il dolore altrui ed il suo (era ammalato di tubercolosi) diventa aggressivo, ribelle, fino a dire: “Dio non esiste, ma sarebbe meglio che esistesse per poter essere segnato a dito di fronte a milioni di sofferenti come ingiusto e crudele”.
Verso la fine della sua vita pensava ad avvicinarsi al cristianesimo.
Francois Mauriac di lui scrive: “Era un’anima essenzialmente cristiana”.
Dostoevskij (1821 – 1881) è stato angustiato a causa della sofferenza degli innocenti in modo particolare. Nel celebre romanzo I fratelli Karamazov, propone l’atteggiamento cristiano di fronte al male avvalendosi dei suoi personaggi: Ivan, parricida, di formazione culturale dell’Europa occidentale, è ribelle contro il cielo e la creazione; lo starets Zosimo, splendida figura di monaco orientale e padre spirituale del buon Aljòsa, col suo modo di agire irreprensibile e in sintonia con l’insegnamento del vangelo, genera fiducia e amore. Aljòsa viene educato a portare nel mondo la fraternità universale e a proporre l’immagine pura di Gesù Cristo nato, morto in croce e risuscitato per la nostra salvezza. Dinanzi alla sofferenza non c’è che volgere lo sguardo al volto sofferente di Cristo.
Bonhoeffer, internato in un disumano campo di concentramento nazista, nella debolezza umana ha trovato la forza sovrumana nella fede cristiana. E mentre saliva il patibolo per essere impiccato, aprendosi alla speranza nella promessa del regno di Dio, ha detto: oggi per me comincia la vita.
Maritain e Raissa, atei, a vent’anni, andavano in cerca del significato della vita presso l’Università La Sorbona di Parigi, e non trovando la risposta sull’ultimo significato, avevano deciso di uccidersi. Ma dall’incontro con lo scrittore Blojs, che si muoveva nella fede come un pesce nelle acque, si convertirono al cattolicesimo, lui dal protestantesimo, lei dall’ebraismo, e divennero, nella cultura, testimoni di Gesù Cristo e annunciatori della vita eterna.
Il male e la Sacra Scrittura
Nel libro di Giobbe è personificata la sofferenza. Giobbe è il simbolo della sofferenza universale, del dramma dell’uomo. È un giusto messo alla prova, che rimane sempre fedele a Dio e che si chiede: perché tanto dolore nell’innocente? Se Dio è buono perché tanta sofferenza? Viene una risposta: non puoi sapere tutto. Giobbe sente vicino a sé Dio, come non mai, e ripone in Lui la sua fiducia. Ma la risposta sull’origine del male resta nel mistero.
Per la Bibbia la domanda più importante non consiste nel domandare: perché il male, ma come vivere nella storia dove il bene e il male crescono insieme.
Nella parabola evangelica relativa al grano e alla zizzania, gli agricoltori chiedono: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli risponde: un nemico ha fatto questo (Mt 13, 1ss.). Non aggiunge altro. L’essenziale è stato detto. La Bibbia non indugia sul problema teorico, ma su quello pratico. È necessario fermare il male col bene: dove c’è odio far risplendere l’amore; dove c’è vendetta rispondere col perdono.
Il mistero della croce
Che cos’è accaduto in quel venerdi santo per la storia del mondo? Il vangelo secondo Marco (15,33) e quello secondo Matteo (27,45) riportano il grido di Gesù: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù chiede il motivo, lo scopo, il fine dell’abbandono. La fiducia che c’è nel salmo 22 è espressa dall’altro grido di Gesù riportata da Luca (23,46): Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In Marco Gesù si rivolge col termine Elì Elì, in Luca col termine più affettuoso, più caldo di Padre. Nell’interrogativo di Gesù crocifisso risuona la voce di tutti i sofferenti della storia.
Nella croce è stata stipulata la nuova ed eterna Alleanza su un evento tragico dell’esistenza reale di Gesù. Nell’ultima cena, ha scritto Vanhoye: Gesù operò una trasformazione esistenziale, straordinaria che deve provocare stupore. Egli assunse in anticipo la propria morte, la rese presente nel pane spezzato e nel vino versato, e capovolse completamente il senso dell’evento, trasformandolo in mezzo per stabilire l’Alleanza a beneficio di tutti.
All’atroce morte Gesù ha dato un senso diametralmente opposto, quello di un’Alleanza perfetta e definitiva. Col sangue versato in una morte violenta ha suggellato la redenzione2.
“Redenzione” significa riacquistare. Che cosa si riacquista? Si riacquistano, nel presente, doni soprannaturali persi per il peccato e nel tempo escatologico l’integrità di tutto l’essere. Nel Miracolo del paralitico (Mc 2,25) c’è un chiaro simbolo: il paralitico viene giustificato ed anche guarito nel corpo.
Da parte nostra è necessario essere fedeli all’Alleanza del cenacolo e perseverare nella fede in Gesù Cristo, unico Mediatore e Salvatore dell’umanità.
Conclusione
La croce è potenza e sapienza di Dio, è scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani. È stoltezza per quelli che si perdono, ma potenza di Dio per quelli che si salvano (cfr 1 Cor 1,23).
O mistero inesauribile
dell’umana Redenzione:
morendo sopra il patibolo
Cristo sconfigge la morte.
Il crocifisso della venerabile Madre Speranza, esposto nel Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, ricorda nei simboli l’Eucaristia, che rende presente il sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo, la nuova Alleanza, e la regalità universale del Signore risorto e glorioso alla destra del Padre.
1 CLARL PEGUY, Il dramma di Giovann D’Arco, Ed. Paoline.
2 VANHOYE A., La Civiltà Cattolica, 1992 1 118 – 132.
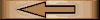 |
|
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento
25 luglio, 2005