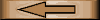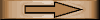Studi P. Ubaldo Terrinoni Biblista
"Fare la verità nella carità"
(Ef 4,15)
1. Legame inscindibile tra verità e carità
L’esperienza insegna che questo saggio principio paolino trova spesso clamorose smentite nella realtà del vivere quotidiano. Non mancano, infatti, coloro che, a modo di stile di vita, affermano: "La verità va detta sempre anche quando ferisce", "la prima carità è la verità", "a me piace parlare chiaro", "bisogna avere il coraggio delle proprie idee per saper dire anche parole ruvide aspre e scomode", "la verità non sopporta sussurri infrasuoni e mimetismi verbali ma ama la franchezza e la sincerità", "bisogna avere il coraggio di dire bianco al bianco e... nero al nero". E non manca chi, per dar conferma alle proprie convinzioni, si appella a Gesù che richiama a un parlare limpido e semplice, espresso soltanto con un "si" o con un "no" (Mt 5,37).
E, così, con lo specioso motivo della "verità", si aprono dolorose ferite nell’anima difficilmente rimarginabili; si provocano intime nascoste sofferenze; si scavano fossati profondi tra persone; si coltivano torti mal digeriti, risentimenti, antipatie, gelosie... Con la scusa di voler "fare la verità", si tiene nascosta in zone recondite una "lama" affilata per estrarla al momento opportuno e colpire. In questo contesto comunitario prosperano malumori, tensioni, aggressività a fior di pelle, egoismi, chiusure, esclusioni, amarezze, silenzi pesanti, atteggiamenti di rifiuto..; Con il falso intento di voler correggere ingiustizie e storture, si semina in abbondanza lo spirito di zizzania, si cerca di influenzare i più deboli per trarli dalla propria parte e, con abile dialettica, si producono divisioni, distanze e lacerazioni.
"Si è umani", si dice! Ed è ben vero. Proprio per questo, l’apostolo Paolo, consapevole delle facili e gravi deviazioni che si producono in una comunità, si indirizza ai cristiani di Efeso e suggerisce di tener sempre strettamente congiunte la verità e la carità. Mai l’una senza l’altra; non l’una contrapposta all’altra; non prima l’una e poi l’altra, ma ambedue sempre insieme, in un profondo rapporto circolare, perché l’una reclama l’altra. Anzi, quanto più impegnativo e delicato è il dovere della verità tanto più necessaria deve risultare la carità per illuminare, riscaldare e offrire nel giusto modo la verità.
Lo stretto legame tra verità e carità è messo bene in rilievo anche dal recente documento pastorale dell’Episcopato italiano, per gli anni ‘90. Al numero 10 recita: "Una delle mete pastorali dell’attuale decennio sarà proprio quella di mettere in più chiara luce, nella coscienza e nella vita dei credenti, l’intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella carità, secondo il detto paolino "fare la verità nella carità (Ef 4,15) " (C.E.I., Evangelizzazione e testimonianza della carità). Risulta chiaro dal documento che il suo centro ermeneutico non è né la verità annunziata né la carità praticata, bensì il nesso tra le due. Interessa vivamente ai Vescovi italiani, in questo scorcio di tempo che corre verso il terzo millennio, che la Chiesa sappia intrecciare in un intenso rapporto l’istanza dell’annuncio della verità con il dinamismo della carità.
2. Il detto paolino nel suo specifico contesto
Il noto principio paolino ("fare la verità nella carità") lo si legge nella seconda parte della lettera agli Efesini, nel contesto di una pressante e appassionata esortazione alla comunione fraterna e al rispetto delle differenze dei doni di ciascuno. Dopo l’insegnamento dottrinale o cherigmatico della prima parte (1,1-3,21), l’apostolo fa seguire la sezione parenetica (4,1-6,20). Il verbo greco parakalèo ("esorto, scongiuro"), che apre la seconda parte, in 4,1 è un termine proprio dello stile epistolare paolino che introduce le indicazioni concrete, pratiche che egli desidera comunicare alle comunità.
Sullo sfondo della vita quotidiana della comunità cristiana di Efeso sono spuntate tre pericolose emergenze che minacciano seriamente l’unità ecclesiale: la discordia tra i cristiani, la difficoltà a riconoscere e valorizzare i diversi carismi e ministeri, nonché una certa superficialità dottrinale che è facile porta d’ingresso per errori grossolani o, quanto meno, per deviazioni di fede. Paolo stigmatizza la discordia che serpeggia tra i cristiani, a causa di una meschina volontà di supremazia e di reciproca intolleranza (4,2ss). Esorta ad accogliere la diversità dei ruoli come autentica ricchezza della comunità (4,7-13). E sollecita ad aprire gli occhi sul grave pericolo che minaccia la stabilità del loro "edificio" di fede. Tutti corrono il rischio di essere sballottati da qualsiasi vento di dottrina, per mancanza di un serio approfondimento della verità cristiana (4,14-16).
Ovviamente, non si tratta di una verità astratta né di un vago sentimentalismo religioso, né di un moralismo nebuloso. Si tratta, invece, del Vangelo autentico, sine glossa, che deve essere accolto e vissuto in un clima di carità, in un contesto ecclesiale, contrassegnato in permanenza dall’amore fraterno (greco agàpe). Questo termine risulta così importante che ricorre per ben tre volte nel brano: vv. 2.15-16. I cristiani di Efeso, di fronte a queste serie minacce, sono chiamati a serrare le file dell’unità fraterna per arginare i tre reali pericoli, facendo la verità nella carità.
La frase è espressa, nel testo originale, con un participio presente che ha valore di imperativo: alethèuontes (Volgata: veritatem facientes). Il verbo alethèuo può significare sia "dire la verità" come anche "fare" o "vivere la verità". Secondo una lettura più accreditata tra gli esegeti, qui non si tratta tanto del semplice "dire" o "annunciare la verità" del Vangelo, quanto dell’impegno a "viverla" per proporla efficacemente con la vita. Non, dunque, una verità slegata dall’esistenza quotidiana, bensì congiunta e identificata con essa. Solo così la proposta di salvezza si fa strada nel mondo mediante il contributo vitale e convincente del cristiano.
Tuttavia, deve risultare chiaro che la verità non può essere fatta in qualunque modo, bensì "nella carità" (gr. en agàpe, v. 15). Ciò vuol dire che "l’annuncio della verità è non soltanto congiunto con l’amore, ma (è) situato nell’amore. La verità del Vangelo si esplica e si manifesta nell’amore" (H. Schlier). L’amore è il clima permanente all’interno del quale si attua e si svolge l’incontro con la verità per assimilarla e viverla. Il cristiano deve tradurre in espressione d’amore e di vita la verità che intende offrire al mondo: ai vicini e ai lontani.
Non sono ammissibili, perciò, aride speculazioni e freddi intellettualismi. Non è consentito donare la verità con animo distaccato, assente e disinteressato. La verità non è merce che si compera o si distribuisce dietro compenso, ma è una realtà viva, dinamica, in incessante comunione con il cristiano, il quale ha estremo bisogno di verità non meno che di amore. La verità, dunque, va partecipata sempre con un proporzionato quoziente affettivo. Verità e carità, verità e affetto fraterno devono direttamente rapportarsi alla capacità recettiva del destinatario.
È precisamente così che il calore affettivo salda l’animo di due fratelli e li apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, alla comunione e alla serena ricerca della verità etica e dogmatica.
Perciò, non è sufficiente donare la verità tout court, ma si richiede di donarla e di donarsi nella carità. Ed è questa la via sicura per conseguire il possesso della verità, anche quando questa è dura da accettare. La verità è il traguardo da raggiungere, la carità è la strada maestra da percorrere. La verità è l’isola misteriosa da scoprire e da conoscere, la carità è la barca che conduce fin là.
3. Comprende pienamente solo chi ama
Verità e carità insieme introducono alla conoscenza di altri "piccoli mondi" che, per tante ragioni, sono differenti dal "nostro"; conoscere gli altri, ci aiuta spesso a conoscere meglio noi stessi. Verità e carità insieme fanno cadere pregiudizi, prevenzioni, sipari e diaframmi che nascondono persone, progetti e valori. Verità e carità insieme confermano, sul terreno dei fatti, che l’incontro tra fratelli è possibile, senza che si trasformi in scontro; che si possono aprire gli occhi su miserie ed errori nostri e altrui, senza restarne sorpresi o smarriti; che ci si può conoscere, comprendere e amare anche al di là dei difetti e delle povertà, per fare di una comunità come "un’unica persona". La verità, quando è permeata di carità, non si impone mai, ma si propone, si offre, si dona; ama la discrezione, rispetta le differenze, favorisce il pluralismo.
"La verità che non è caritatevole -afferma S. Francesco di Sales - nasce da una carità che... non è vera". La verità senza la carità è arroganza; la carità senza la verità è ipocrisia. Chi annuncia la verità senza la carità, è un freddo e stanco ripetitore di una verità chiusa e congelata in schemi angusti e aridi; manca di fantasia, di inventiva, di originalità. E proprio questo è l’errore grossolano del fratello maggiore, nella parabola del figliol prodigo (Lc 15,25-32). Pretende che il padre applichi un codice morale di verità, escludendo il cuore; che al centro del menage familiare vi sia un rigido ordinamento disciplinare e non il cuore a moderare, e che il padre svolga il ruolo di semplice e imparziale ragioniere per registrare meriti e demeriti dei figli. Il maggiore si crede giusto, ritiene di essere nella verità e di detenerne il monopolio esclusivo. Non avverte affatto il bisogno di un confronto. Ed invece, proprio per questo, lo si scopre gretto e povero, più povero del prodigo, il quale è almeno ricco di un cuore dilatato dalla sofferenza e da un’amara esperienza, e dichiara di avere estremo bisogno dell’amore paterno per ricominciare tutto da capo.
La verità e la carità insieme sono necessarie per cogliere la vera identità dell’altro. Amor ipse intellectus est, insegnavano i medioevali: "l’amore è già intelligenza, conoscenza", è già verità. E come è vero! Si capisce un fratello solo nella misura in cui lo si ama. L’amore rende più penetrante lo sguardo dell’intelligenza; va al di là delle apparenze, al di là di qualche.. miseria per cogliere nel cuore la realtà intima e più vera del fratello. "Dicono che l’amore è cieco - ripete André Frossard-. Non è vero; è l’unico che ci vede, perché vede nella persona amata una bellezza che chi non ama non vede".
Più che un’acuta introspezione psicologica, è l’amore che abilita l’occhio a penetrare nelle profondità abissali di una persona, per scendere in quelle zone sacre, di mistero, che restano inaccessibili ai freddi calcolatori, ai curiosi e agl’indifferenti, e si aprono esclusivamente ad un cuore amico che esplora e ricerca con sincerità e discrezione. E questa è l’intelligenza del cuore!
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento 09 giugno, 2023